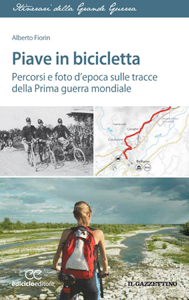Piave in bicicletta

Percorsi sulle tracce della Grande Guerra
Introduzione
Si fa presto a dire Piave. Ma cos’è in realtà il Piave? Considerarlo solo un fiume è riduttivo perché è molto, ma molto di più: per certi versi incarna l’essenza stessa del Veneto, rappresenta la sua anima, il suo cuore, è l’arteria principale che per millenni ha infuso la linfa vitale fecondandone il territorio.
Il Piave è stato una madre prodiga e generosa, ha favorito scambi e commerci, prodotto benessere, creato immense ricchezze, ha connesso mondi diversi, li ha amalgamati tra loro, ha diffuso cultura. Ed essendo madre per secoli è stato declinato al femminile, la Piave.
Ormai per tutti noi il Piave è diventato il fiume sacro per eccellenza, ma questa sua recentissima sacralità è stata ottenuta grazie al sacrificio e all’eroismo di migliaia di giovani vite umane che ne hanno arrossato le acque col proprio sangue. E il Piave ne custodisce la memoria – e spesso anche i corpi. Perciò in quest’ultimo secolo è stato forzatamente tramutato in maschio, la retorica bellica non poteva certo permettersi diversamente…
La guerra
Tra il novembre del 1917 e il novembre del 1918 il Piave nel suo medio e basso corso – in pratica dalla stretta di Quero alla foce – è stato teatro di tre cruente e decisive battaglie che hanno determinato le sorti della prima guerra mondiale. Cioè la battaglia d’Arresto (13-26 novembre 1917) – avvenuta dopo la rotta di Caporetto – che riuscì ad attestare il fronte sulla sua sponda destra; la battaglia del Solstizio (15-25 giugno 1918), che respinse l’ultima offensiva nemica e non fece passare lo straniero; la battaglia Finale (24 ottobre-4 novembre 1918), che decretò la conclusione vittoriosa della guerra. Le numerosissime tracce e i ricordi di questi eventi costituiranno una prima traccia del palinsesto del viaggio.
Il nostro procedere si dipanerà quindi attraverso una vera e propria toponomastica dell’eroismo evidenziata dai nomi di località (isola dei Morti, cippo degli Arditi, Santa Maria della Vittoria), di cittadine (Nervesa della Battaglia, Moriago della Battaglia, Sernaglia della Battaglia, Fagarè della Battaglia, Losson della Battaglia), e un’infinità di riferimenti nei nomi delle vie intitolate a comandanti, generali, eroi, armate, battaglie. Per non parlare dei numerosissimi sacrari, monumenti, sacelli, pili, cimiteri di guerra che incontreremo lungo la strada.
La storia
Pedalare oggi lungo il Piave significa quindi compiere un lento viaggio di conoscenza attraverso un territorio culturalmente omogeneo: infatti il Piave innerva il Veneto per tutta la sua lunghezza, mantenendo la testa sulle Dolomiti e i piedi a bagno nell’Adriatico, a fianco delle acque salmastre della laguna di Venezia. Vale a dire che si parte da un patrimonio dell’Umanità – le Dolomiti – per arrivare a un altro, la laguna di Venezia. E in mezzo c’è lui, il corso d’acqua che trae origine dal monte Peralba – vetta delle Alpi Carniche – e benefica tutta la vallata con la sua millenaria storia di principale arteria del traffico commerciale.
Per secoli e secoli, già ai tempi dei romani, le sue acque sono state solcate da innumerevoli zattere che trasportavano a valle manufatti e beni di prima necessità, soprattutto quel legname proveniente dai preziosissimi boschi del Cadore, del Cansiglio e del Montello che risulterà decisivo per la vita stessa della Serenissima, indispensabile elemento per costruire abitazioni e allestire la flotta più importante dell’Adriatico. E noi ripercorreremo pedissequamente la stessa rotta degli zattieri, sebbene via terra, rivivendo in qualche modo emozioni simili; ammireremo città d’arte, ville venete, borghi deliziosi, visiteremo siti archeologici e piccoli musei.
Pedaleremo anche a fianco di aree golenali, parchi e oasi naturali che in questi ultimi anni sono stati istituiti, quasi una sorta di risarcimento alla natura e la testimonianza di un approccio diverso col territorio e col fiume dopo il lungo periodo di sfruttamento incondizionato delle sue materie prime (soprattutto ghiaia e acqua) e di indiscriminate colate di cemento per l’edificazione di viadotti, gallerie, nuove arterie stradali, ponti, invasi, condutture e dighe che hanno radicalmente segnato il paesaggio.
Il viaggio
Dal punto di vista ciclistico il percorso non è molto impegnativo, dato che si sviluppa complessivamente in discesa, pur con alcune contropendenze a volte anche impegnative. Si parte dai 1830 metri del rifugio Sorgenti del Piave per giungere al livello del mare della foce di Marina di Cortellazzo, circa 230 chilometri dopo.
Davanti ai nostri occhi sfileranno numerose cittadine e borghi da visitare con attenzione: Sappada, Santo Stefano di Cadore, Pieve di Cadore, Longarone, Belluno, Mel, Feltre, Alano di Piave, Cornuda, Valdobbiadene, Nervesa della Battaglia, Maserada, Ponte di Piave, San Donà ed Eraclea, solo per citare le località principali.
E durante la nostra discesa incroceremo anche altri percorsi ciclo-pedonali che portano verso diversi territori, costituendo il primo nucleo di un circolo virtuoso che favorisce la mobilità lenta e sostenibile (“La lunga via delle Dolomiti” in direzione di Cortina e poi di Dobbiaco, connettendosi con le ciclabili della val Pusteria, oppure il “Cammino delle Dolomiti”).
Si può pensare di percorrere il tragitto anche tutto d’un fiato, in una sola volta, ma sono quasi 230 chilometri e sinceramente la bicicletta suggerisce ritmi più rilassati, soprattutto per assaporare i numerosissimi stimoli offerti.
Noi qui proponiamo una scansione di sei diverse tappe (una di queste a dire il vero è una variante sul lato opposto, per cui di fatto sono cinque), al cui arrivo è sempre presente una stazione ferroviaria cui far riferimento per utilizzare eventualmente il sistema di trasporti integrato treno più bici.
Al momento attuale l’itinerario si svolge quasi esclusivamente su strade a traffico promiscuo, in qualche caso a bassissima percorrenza (ad esempio la tranche da Calalzo a Belluno, segnalata da apposita cartellonistica come ciclopista “La lunga via delle Dolomiti”), ma in gran parte su provinciali con alcuni tratti anche abbastanza trafficati: è quindi necessario essere prudenti e rispettosi del codice della strada. Abbiamo fatto ad esempio la scelta di evitare la statale sulla destra Piave da Belluno verso Feltre privilegiando la sponda sinistra, un po’ meno frequentata.
Siamo comunque in attesa che venga realizzata una pista ciclabile lungo il fiume, al vaglio delle istituzioni e il cui progetto è già stato presentato in occasioni pubbliche, che consentirebbe un maggior agio nell’affrontare in sicurezza questi territori e certamente darebbe un impulso decisivo alla mobilità dolce e al turismo su due ruote. Come succede nei paesi europei più avanzati. Non ci resta che sperare... Nel frattempo seguiremo il percorso segnalato.
La buona tavola, il buon bere
Il nostro sarà un viaggio anche attraverso le peculiarità culinarie venete, perché l’andamento lento della bicicletta consente un approccio approfondito e meditato anche su queste tematiche, esaltando quello che risulta essere un anagramma perfetto: BICI/CIBI.
Nel testo troverete infatti numerose indicazioni relative all’aspetto gastronomico, con consigli e indirizzi specifici. D’altronde il territorio attraversato dal Piave ha molteplici prodotti agroalimentari tradizionali e tutelati, dal pastin (misto di carne suina e bovina aromatizzate) al formaggio Piave, dai fagioli di Lamon ai marroni di Combai e agli asparagi bianchi di Cimadolmo, dal prosecco di Conegliano-Valdobbiadene ai vini del Piave. Ed è di conseguenza solcato da altrettante strade a tema (ad esempio la strada dei marroni, quella del prosecco, il percorso del miele bellunese), come pure da antichi tracciati romani o medievali (la famosa via Claudia Augusta Altinate è un esempio del primo tipo, la via Callis Alta lo è del secondo) che incontreremo più volte.
La cultura
Il nostro lento procedere verso la foce verrà pure accompagnato dalla lettura degli scritti di alcuni letterati che hanno rivolto la loro attenzione a questi luoghi. Consulteremo quindi i versi di Carducci dell’ode Cadore con i suoi riferimenti al patriota Pier Fortunato Calvi, le strofe della poesia Ucciso di Ernest Hemingway dedicata al conterraneo sepolto nel cimitero di Fagarè della Battaglia, o quelle di D’Annunzio de La preghiera di Sernaglia scritta a ridosso della battaglia Finale. Scolpito sulla Pietra della rimembranza, presente in ogni cimitero di guerra britannico, leggeremo invece il verso – in realtà un versetto biblico – scelto da un altro premio Nobel per la letteratura, Rudyard Kipling, per essere inciso in tutti i cimiteri di guerra britannici, mentre nella nostra planata verso Mel ci faranno compagnia le parole del bellunese Dino Buzzati. Nel basso Piave invece sentiremo riecheggiare gli scritti di Goffredo Parise, residente negli ultimi anni di vita a Ponte di Piave, e le poesie dialettali di Giacomo Ca’ Zorzi, in arte Giacomo Noventa. E ci faranno da guida pure le ottave di un semisconosciuto poeta locale dal cognome illustre, don Antonio Vecellio, che ha dedicato al nostro fiume un mastodontico componimento di circa 2000 ottave, nulla di particolarmente memorabile dal punto di vista letterario ma assai interessante per l’omaggio riservato al Piave. Un fiume di parole.
Incroceremo anche altre storie, altre persone che hanno lasciato importanti tracce: pittori come Tiziano, o Ippolito Caffi o Cima da Conegliano o Giovanni da Mel, scultori come Andrea Brustolon, che hanno contribuito con il loro lavoro a rendere grande questo territorio.
Gente ispirata, tosta, determinata, come ce n’è ancora molta da queste parti. Razza Piave.
domenica 27 aprile 2014